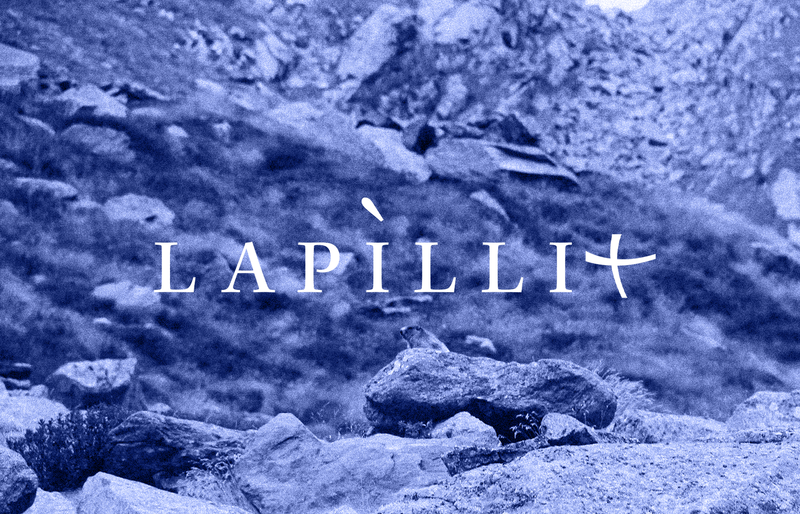Il richiamo acuto della marmotta alpina echeggia da tempo tra i pascoli d'alta quota. Oggi però quei richiami suonano più come un grido di allarme visto che la sopravvivenza di questa specie è minacciata su più fronti. Nel numero di Lapilli+ di questo mese, il giornalista scientifico e naturalistico Roman Goergen racconta cosa sappiamo sullo stato di salute di questo iconico abitante delle Alpi e di come il loro declino parli anche del futuro dell'ecosistema alpino.
Il sacco di iuta appoggiato sull'erba si gonfia e si sposta. Si intuisce il contorno di una creatura litigiosa lunga circa 40 centimetri che si dimena al suo interno.
L'unica cosa che le impedisce di uscire e correre via è il ginocchio di Samuel Ginot. Il biologo francese, che quest'estate ha lasciato il suo laboratorio all'Università di Montpellier per le vette di montagna, fissa un'estremità del sacco mentre prepara gli strumenti. Infine, allenta il cordoncino quel tanto che basta per far apparire una testa: una marmotta alpina femmina, ancora visibilmente indignata.
A differenza della marmotta, la situazione è ideale per Ginot, che si trova lì per misurare la forza del morso di questo roditore di quattro chilogrammi. Un dispositivo a forma di pinza viene messo davanti al naso della marmotta, che lo morde con i suoi caratteristici incisivi. Il morso invia un segnale elettrico tramite un cavo a un piccolo lettore. Ginot annota il risultato sul suo taccuino grande quanto il palmo di una mano: 130 newton, più o meno la forza del morso di una volpe rossa.

“Voglio saperne di più sulla forza del morso di questi animali e capire che ruolo svolge nei loro comportamenti sociali. Gli animali dominanti hanno un morso più forte? Il morso è più debole dopo il letargo? In che modo sesso, età o stagione influenzano la forza del morso?”, spiega Ginot.
Dai due contrassegni sulle orecchie, il biologo capisce che questa marmotta è già nota ai suoi colleghi e che è una femmina dominante, che governa un territorio e una famiglia allargata. Una volta liberata, la marmotta si lancia in una delle tante tane disseminate sui verdi pendii dell'Aiguille de la Grande Sassière, a circa 2.500 metri sulle Alpi francesi, vicino al confine italiano.
In questa stretta valle, dove il torrente Ruisseau de la Sassière si snoda tra le vette, l'Università di Lione conduce dal 1990 uno degli studi sulle marmotte alpine più completi al mondo, monitorando 2.200 ettari. Per secoli, queste sentinelle dalla voce fischiante sono state il simbolo delle Alpi. Le misurazioni della forza del morso di Ginot si uniscono a una serie di dati accumulati in oltre tre decenni, che documentano come il mondo delle marmotte stia cambiando rapidamente. I cambiamenti climatici stanno riducendo le possibilità di sopravvivenza dei loro piccoli, sconvolgendo le strutture sociali e persino alterando la loro fisiologia.
“La salute delle marmotte riflette la salute delle Alpi”, afferma il biologo Christophe Bonenfant, che guida il team di ricerca di Lione dal 2019. “Sono una specie sentinella” e, avverte, potrebbero diventare il volto del cambiamento climatico in alta montagna.
Le temperature medie sulle Alpi sono aumentate di circa due gradi centigradi dalla fine del diciannovesimo secolo, circa il doppio della velocità globale. I ghiacciai si stanno ritirando; le pareti rocciose si sgretolano dopo anni di siccità. Se le tendenze attuali continueranno, molti dei ghiacciai della catena montuosa potrebbero scomparire completamente prima della fine del secolo.
“La quota delle nevicate continua a spostarsi più in alto”, afferma Nicolas Vernon, guardia forestale della Riserva naturale della Grande Sassière. “Dove prima c'era un unico lago di disgelo, ora ce ne sono tre”.
La marmotta alpina è quella che gli scienziati chiamano una testimonianza dell’era glaciale. Durante il Pleistocene, viveva in tutte le pianure d'Europa. Con la fine dell'ultima glaciazione e il riscaldamento del clima, la specie si è adattata al freddo e si è ritirata verso l'alta montagna, dove un letargo di sei-sette mesi le permette di sopravvivere. Ma l'adattamento alla vita in alta montagna è avvenuto a un costo.
“Sono già sopravvissute a un episodio di cambiamento climatico, il riscaldamento che ha posto fine all'era glaciale”, afferma Bonenfant. “La domanda è se questa volta riusciranno ad adattarsi abbastanza rapidamente, con il ritmo dei cambiamenti a cui stiamo assistendo ora”.

Alla stazione di ricerca della Grande Sassière, Rebecca Garcia siede su una panchina di legno fuori dallo chalet che funge sia da alloggio estivo che da laboratorio per il team di ricerca. Ogni anno, per due mesi da metà maggio a metà luglio, una squadra, solitamente composta da sei persone, lavora e dorme qui, raccogliendo osservazioni giornaliere nel regno delle marmotte. In qualità di assistente tecnico per l'Università di Lione, Garcia coordina il lavoro sul campo e dirige gli studenti che ogni mattina si sparpagliano nell'area di studio.
Ai margini del sentiero escursionistico che passa davanti allo chalet, una marmotta maschio è in piedi con la coda ritta. La agita vigorosamente mentre strofina le guance contro il terreno per depositare una secrezione pungente dalle ghiandole facciali: un avvertimento profumato per gli intrusi.
La marmotta alpina vive in gruppi sociali complessi composti dalla coppia dominante e un numero variabile di subordinati. Per quei subordinati che aspirano al potere le opzioni non sono molte: o attaccano l’animale dominante per rivendicare una porzione di terreno o sfidano il vicino oppure rovesciano i propri genitori. Una volta raggiunto lo scopo, i nuovi governanti si assicurano che i loro geni dominino la famiglia.
A causa del letargo di sei-sette mesi, le marmotte alpine si sviluppano lentamente, raggiungendo la maturità sessuale solo dopo tre o quattro anni. Anche allora, molte rimangono nel gruppo natale come “aiutanti” della coppia dominante, aiutando ad allevare i piccoli e condividendo il calore corporeo in inverno per mantenere calda la tana. Ma questi meccanismi sociali, affinati nel corso dei millenni, sono ora sconvolti dai cambiamenti climatici.
“Stiamo assistendo a cucciolate sempre più piccole”, riferisce Garcia. “In passato, c'erano quattro o cinque cuccioli; ora sono scesi a tre o quattro. E le madri sono spesso in condizioni peggiori quando escono dal letargo”.
La colpa è della neve, o meglio, della sua assenza. Il manto invernale sopra le tane si sta assottigliando, il che, paradossalmente, rende il sottosuolo più freddo perché c'è meno isolamento. Le marmotte possono tollerare temperature fino a circa quattro gradi centigradi nelle loro camere di ibernazione. Al di sotto di questa temperatura, il loro corpo deve generare calore extra, bruciando più energia e riserve di grasso. “Quindi escono dal letargo in condizioni peggiori e le femmine partoriscono meno piccoli”, afferma Bonenfant. È una spirale discendente che il team è determinato a monitorare da vicino, documentando i cambiamenti nelle condizioni corporee e nella riproduzione anno dopo anno.
A pancia in giù nell'erba, la studentessa di biologia Aure Hirigoyen rimane immobile per tre ore davanti alla tana di una marmotta. La sua missione di oggi è catturare i cuccioli per sottoporli a un test: un compito arduo. Nei primi tre giorni dopo l'uscita dalla tana, i piccoli sono abbastanza ingenui da poter essere presi in mano. Dopodiché, i ricercatori devono posizionare delle trappole: grandi gabbie innescate da una piastra con dei pesi e l’utilizzo di esche di melassa e cibo per conigli.
Ma questa volta la trappola non serve. Tre cuccioli si avventurano allo scoperto e Hirigoyen lancia un sacco di iuta sopra l'ingresso della tana per non lasciare loro una via di fuga. Due riescono a scappare, ma il terzo finisce tra le sue mani.
Nel laboratorio dello chalet, il cucciolo viene anestetizzato. Garcia si mette al lavoro: lo pesa, ne misura le proporzioni corporee e la temperatura e preleva campioni di sangue, feci e pelo. Ogni animale riceve un microchip e un contrassegno auricolare (due per i dominanti). Viene annotata la famiglia di origine e tutti i dati vengono inseriti in un meticoloso registro di famiglia. “Se l'animale è già stato in nostro possesso, aggiorniamo i registri”, spiega Garcia.
Mentre il cucciolo si sveglia in una scatola di cartone, Garcia scrive un nuovo numero sulla lavagna: 2.302. “Il numero totale di singole marmotte che abbiamo studiato finora”. Nel giro di poche ore, campioni e dati saranno inviati all'Università di Lione per essere analizzati da Bonenfant.
Sebbene le marmotte alpine rimangano abbastanza diffuse - l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura le classifica come “a rischio minimo” nonostante un calo annuo della popolazione di circa il quattro percento - i dati di Lione mostrano chiare tendenze negative che, secondo i ricercatori, meritano un'attenta osservazione. Le cucciolate si stanno riducendo, i tassi di sopravvivenza dei cuccioli sono in calo e le dimensioni corporee medie si stanno riducendo costantemente dall'inizio degli anni 90. Per un animale che si è adattato al freddo, questa è una cattiva notizia.


La studentessa di biologia Aure Hirigoyen strofina una giovane marmotta liberata con la terra della sua tana per farla accettare nuovamente dalla madre. I cuccioli inizialmente sono abbastanza ingenui da poter essere presi in mano. Dopodiché, i ricercatori devono posizionare delle trappole innescate da una piastra con dei pesi e riempite con esche di melassa e cibo per conigli (Roman Goergen).
Poco oltre le vette francesi, a meno di 20 chilometri dal sito di studio della Grande Sassière, si trova il Parco nazionale del Gran Paradiso. Qui, dal 2006, l'ecologa comportamentale Caterina Ferrari studia i cugini italiani delle marmotte francesi, riscontrando molti degli stessi cambiamenti sociali dei suoi colleghi di Lione.
Ferrari ha notato l'inizio di un adattamento comportamentale. “Le marmotte di solito vivono in famiglie numerose. Ma con la riduzione del loro habitat, bisogna chiedersi se questa struttura sociale sia ancora vantaggiosa. Non credo che lo sia: non c'è più abbastanza spazio e cibo”, afferma Ferrari. Si aspetta che gruppi più piccoli e nuovi modelli sociali diventino la norma.
Nelle Alpi italiane, la quota dei boschi si sta alzando e quelle che un tempo erano praterie montane e pascoli alpini sono ora giovani foreste. “Dove lavoro, solo pochi anni fa c'erano prati aperti e le marmotte erano ovunque. Ora ci sono boschi e le vedo muoversi tra cespugli o piccoli alberi. ... È un cambiamento enorme per una specie così ben adattata alla vita nelle praterie alpine aperte”, dice.
Non è solo la temperatura a determinare il cambiamento. Molti prati alpini sono paesaggi creati dall'uomo, mantenuti per secoli dallo sfalcio o dal pascolo del bestiame. Con il declino dell'agricoltura tradizionale in alta quota, i pascoli crescono incontrollati, riducendo le aree dove le marmotte preferiscono andare a cibarsi. Le nuove foreste portano anche nuovi predatori: le volpi rosse ora cacciano in luoghi un tempo dominati solo dalle aquile reali, prendendo di mira in particolare le giovani marmotte. Proteggere i pascoli alpini che ancora ci sono, ritiene Ferrari, sarebbe un primo passo importante per aiutare la specie.
Ferrari ha inoltre osservato le marmotte alpine spostare il loro areale in entrambe le direzioni: più in alto sui pendii alla ricerca di rifugi più freschi e più in basso alla ricerca di spazio. “Ma salendo molto più in alto si raggiunge la vetta, dove non c'è altro che roccia nuda: niente cibo, niente spazio per scavare tane”, dice. Più in basso, il problema è il caldo. Anche nei loro habitat abituali di media quota, gli animali lottano contro lo stress termico. Nelle giornate calde, ha scoperto il team di Ferrari, le marmotte trascorrono più ore nelle loro tane. “Ora le vediamo persino cercare cibo di notte, ma per un animale che è preda di molti predatori, è una strategia pericolosa”.
Nelle tradizionali roccaforti delle marmotte sugli altipiani, parassiti, batteri e virus sono naturalmente scarsi; molti agenti patogeni non ci arrivano, spiega Markus Ralser, biochimico del metabolismo presso l'ospedale Charité di Berlino. Ma nelle valli, gli animali incontrano una maggiore diversità di agenti patogeni e sono scarsamente attrezzati per combatterli.
Finora, l'isolamento in alta quota ha protetto la specie da numerose minacce. Ma il cambiamento climatico potrebbe abbattere questa barriera, esponendo gli animali ad agenti patogeni e specie invasive contro cui non ha difese. “Non importa quanto sia numerosa la popolazione: senza diversità genetica, si è più vulnerabili a nuove e imprevedibili sfide”, avverte Ralser.
Per ora, grandi colonie di marmotte alpine persistono e nessuno prospetta un crollo imminente. Ma gli scienziati prevedono famiglie più piccole, strutture sociali alterate e un continuo ritiro verso altitudini più elevate. Sulla specie incombe la minaccia di una crisi imprevedibile che potrebbe non essere in grado di affrontare. E per cui Ralser vede solo una soluzione: “Fermare il cambiamento climatico”.

ROMAN GOERGEN
Giornalista scientifico e naturalista, specializzato in conservazione, questioni ambientali, ecologia, biologia, tecnologia e innovazione. Dopo aver vissuto in Sudafrica per oltre 13 anni, attualmente risiede a Londra, dove continua a occuparsi di iniziative legate alla conservazione in Africa, esplorando al contempo quanto condotto nel campo della ricerca scientifica da istituzioni accademiche in Europa e oltre.Grazie per aver letto fin qui, è tutto per questo mese. Ci vediamo a ottobre.
Se questa newsletter ti è stata inoltrata, puoi iscriverti qui per continuare a riceverla. Dedichiamo tempo e amore alla realizzazione di Lapilli+. Pensiamo dunque che sia giusto chiederti un piccolo contributo per la realizzazione di ogni edizione, pari circa al costo di un caffè. Seleziona qui il piano Lapilli premium, i primi due mesi sono di prova. Se lo avessi già fatto, grazie!
Puoi anche sostenerci destinando il tuo 5x1000 a Magma Aps (C.F. 96511280586).
Lapilli+ è la newsletter mensile con contenuti originali (o selezionati) sul Mediterraneo e il suo ambiente a cura di Magma. Se non sai chi siamo, scoprilo qui: leggi il manifesto di Magma.