Oltre alla più stringente attualità, in questo numero di Lapilli segnaliamo diverse storie legate all'acqua: quella che proviene dal cielo in forma di pioggia e quella presente a terra, in laghi turchi, isole greche, zone umide spagnole o albanesi e nei mari tarantini. Ci spostiamo poi in Egitto, da dove viene una lunga inchiesta che racconta come turisti europei, in particolare italiani ma soprattutto maltesi, viaggino per cacciare gli uccelli che ogni anno migrano tra Africa, Asia ed Europa - ma che in Europa, dove si spendono milioni di euro per proteggerli, non si possono cacciare. E come sempre molto altro ancora. Buona lettura!
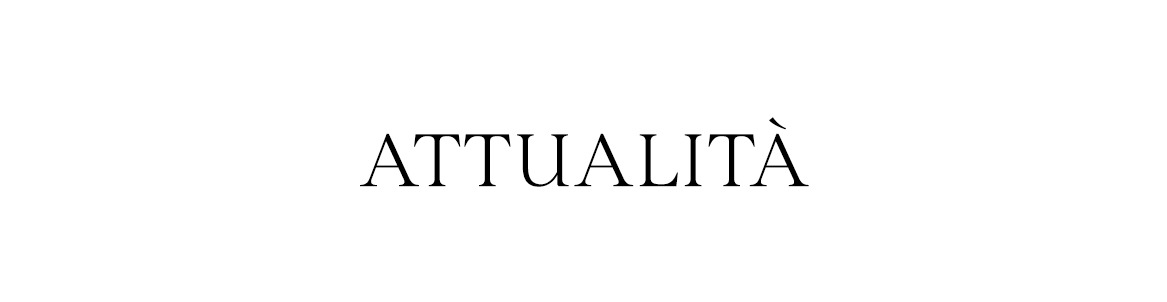
Sconnessi e senza luce. Lunedì, Spagna e Portogallo sono rimasti senza elettricità a causa di un blackout generalizzato senza precedenti. Per buona parte della giornata, treni, metropolitane, semafori, aeroporti e molto altro si è fermato. Anche i mezzi di comunicazione hanno avuto grosse difficoltà. Molti hanno rispolverato gli apparecchi radio per avere informazioni su quanto stesse accadendo. Solo tra la tarda sera di lunedì e la mattina di martedì la situazione è tornata sotto controllo. Le cause del blackout sono ancora da chiarire. Di fatto un calo di energia improvvisa sulla rete ha fatto scattare i protocolli di sicurezza, spegnendo l’elettricità corrente nei due paesi iberici per evitare danni alla rete. Il gestore spagnolo Red Eléctrica ha escluso che si sia trattato di un cyber attacco, mentre qualche figura pubblica spagnola ha chiamato in causa l'affidabilità dell’energia ricavata da fonti rinnovabili dalle quali la Spagna dipende in misura sempre maggiore (Reuters; Bbc; The New York Times). Una serie di grafici pubblicati su El Confidencial spiega le dinamiche che hanno portato al collasso della rete elettrica.

L’anno più caldo. È uscito il rapporto europeo sullo stato del clima o Esotc, redatto dal Servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus e l’Organizzazione meteorologica mondiale, relativo al 2024. Secondo la relazione, il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato e gli ultimi dieci anni i più caldi da quando si hanno dati disponibili. Inoltre il rapporto evidenzia come l’Europa e i suoi fiumi siano sempre più esposti a esondazioni e fenomeni alluvionali. L'Europa è il continente che si sta scaldando di più e questo provoca fenomeni meteorologici sempre più intensi che poi si trasformano in alluvioni. Secondo il rapporto, la percentuale di fiumi che hanno esondato nel 2024 è stata la più alta dal 2013 e la quinta più alta degli ultimi 32 anni. Il mar Mediterraneo, nel suo complesso, ha registrato una temperatura superficiale media annuale di 21,5 gradi, superando significativamente il precedente record stabilito nel 2023 di 21,2. Ad agosto, inoltre, il nostro mare ha raggiunto la temperatura superficiale giornaliera di 28,7 gradi, superando il precedente record stabilito nel luglio 2023 di 28,3. Infine, il rapporto indica come nel 2024 i ghiacciai alpini abbiano perso circa 1,2 metri di spessore continuando un trend di assottigliamento che va avanti da anni.
Piogge intense. È stato un aprile con fenomeni piovosi molto intensi. A Lanzarote, la tempesta Olivier ha causato grandi allagamenti. In Italia, soprattutto in Piemonte, i fiumi sono arrivati al limite e alcuni sono esondati per via delle forti piogge che hanno portato anche abbondanti nevicate in quota. Agli inizi del mese sull'isola di Paros, in Grecia, si sono registrate alluvioni lampo che hanno trasformato le strade in fiumi di fango trascinando le auto fino al mare.
Tornano a riempirsi le paludi di Doñana. Nel mese di marzo intense piogge hanno riempito di acqua le paludi di Doñana, nel sud della Spagna, con un impatto particolarmente marcato nelle zone umide centrali e occidentali. Le piogge hanno migliorato le condizioni ambientali delle paludi - che sono anche parco nazionale - in cronica sofferenza idrica da alcuni anni (TodoAlicante; Phys.org).
Terremoto in Turchia. Un terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro nel mar di Marmara è stato sentito soprattutto a Istanbul dove molte persone sono rimaste ferite. La Turchia è uno dei paesi a più forte rischio sismico del Mediterraneo trovandosi a cavallo di una serie di placche tettoniche. Solo due anni fa il paese fu colpito da un fortissimo sisma di magnitudo 7.8 che provocò la morte di più di 55mila persone (Reuters).

L’impatto delle creme solari. Ogni estate milioni di persone si riversano sulle coste del Mediterraneo e dopo anni di campagne di informazione sui danni dei raggi solari sulla pelle, moltissimi di questi bagnanti si immergono ricoperti di crema solare appena spalmata. Si stima che ogni anno circa ventimila tonnellate di crema solare vengano rilasciate nelle acque del Mediterraneo. L’estate poi passa, ma le sostanze contenute nelle creme restano, soprattutto in tratti di costa dove non ci sono grandi correnti di acqua. Solo di recente si sta facendo chiarezza su cosa contengono le creme solari e che impatto abbiano sulla salute umana e marina. Un’inchiesta finanziata in parte da Journalismfund Europe e pubblicata su France 24, racconta dei recenti studi che sono stati fatti negli ultimi anni su come le sostanze contenute nelle creme solari creino danni soprattutto a molluschi, ricci marini, pesci e coralli. A oggi non esiste una normativa unitaria per regolare l’industria e limitarne i danni ma in alcune parti del mondo, come alle Hawaii e nell’arcipelago di Palau, le creme contenenti l’ossibenzone o octinossato, sostanze che possono contribuire allo sbiancamento dei coralli, sono state bandite.
La gestione dell’acqua dove l’acqua è poca. Con l’estate alle porte segnaliamo inoltre una serie di articoli - realizzata sempre grazie al supporto di Journalismfund Europe - che racconta come alcune isole del Mediterraneo, prese d’assalto dai turisti durante la stagione estiva, vadano in sofferenza idrica. I casi in esame vengono da Sifnos, in Grecia, e dalle Isole Eolie, in Italia, e mostrano come queste isole, già di per sé non particolarmente ricche di acqua, facciano fatica a sostenere la pressione turistica concentrata in pochi mesi. In particolare, a Sifnos, la costruzione di nuove ville con piscina rende la situazione ancora più critica e tesa tra residenti e turisti che si contendono la poca acqua disponibile; mentre, nel caso delle Eolie, emerge una gestione dell’acqua fatta di sprechi e progetti mai finiti. Una sintesi delle storie pubblicate su vari media italiani e greci è disponibile su Journalismfund Europe.

Acqua per il cloud. La gestione dell’acqua sta diventando una sfida sempre più cruciale per lo sviluppo della regione mediterranea. In alcune aree, l’acqua è abbondante e sprecata; in altre, è scarsa e comunque mal gestita. Sempre più spesso, l’acqua viene poi destinata a nuovi utilizzi, come il raffreddamento dei centri dati che alimentano i servizi cloud e l’intelligenza artificiale. Secondo un’inchiesta del Guardian, Amazon, Google e Microsoft stanno ampliando o costruendo nuovi data center in tutto il mondo, molti dei quali situati in regioni già colpite da carenze idriche. Un progetto particolarmente controverso di Amazon nella regione di Aragona, in Spagna, è stato criticato per il suo enorme consumo di acqua ed elettricità. I data center vengono spesso costruiti in zone aride per ridurre la corrosione dei metalli; tuttavia, richiedono enormi quantità d’acqua per il raffreddamento durante il funzionamento. Con l’aumento delle temperature globali e della domanda di servizi cloud e di intelligenza artificiale, si prevede che il fabbisogno idrico di queste strutture crescerà ulteriormente.
A caccia di uccelli migratori. Ogni anno, milioni di uccelli migrano tra Africa, Asia ed Europa, attraversando il Mediterraneo. In autunno si dirigono a sud e in primavera tornano a nord. Da anni l’Europa investe milioni di euro per proteggere gli habitat in cui questi uccelli migrano, nidificano o si riposano durante il viaggio, così come per tutelare le specie più rare e minacciate. Tuttavia, queste protezioni si limitano ai paesi europei, spingendo alcuni cacciatori a spostarsi lungo le rotte migratorie per sparare agli uccelli. È il caso dei cacciatori maltesi — e talvolta anche italiani — che si recano in Egitto, dove le tutele sono deboli e gli uccelli migratori abbondano. Con l’aiuto di tour operator locali, questi cacciatori vengono accompagnati in aree dove si concentrano le specie più ricercate. Una volta uccisi, gli uccelli vengono illegalmente riportati a Malta, dove vengono imbalsamati ed esposti come trofei nei salotti maltesi.
Secondo le stime dell’Unione europea, ogni anno nel bacino del Mediterraneo vengono ammazzati 25 milioni di uccelli migratori. Questa inchiesta, durata 15 mesi, mette in luce i limiti delle protezioni europee, il contrasto tra differenti contesti culturali ed economici (in alcuni casi, infatti, questi viaggi rappresentano l’unica fonte di reddito per le comunità locali egiziane) e il tragico destino di milioni di uccelli migratori (Mongabay).

Piccoli mari. Abbiamo spesso parlato del mar Menor in Spagna, una grande laguna che ha grossi problemi di inquinamento e che da poco è stata dichiarata un'entità giuridica con dei diritti propri, tra cui il diritto a essere protetta, un po' come una persona fisica. Goldy Ann Levy della nostra scuola magmatica di giornalismo ambientale ne ha scritto su Lucy sui Mondi, un nuovo progetto editoriale legato a Lucy sulla Cultura e diretto dal filosofo della scienza Telmo Pievani. Ma in questo numero di Lapilli parliamo anche di un altro piccolo specchio d’acqua, questa volta nel sud dell’Italia: il mar Piccolo di Taranto. Il mar Piccolo e il mar Grande sono due bacini d’acqua collegati tra loro - con il mar Grande a sua volta comunicante col mare aperto. Nei fondali di questi mari interni si trovano molte sorgenti di acqua dolce fredda e questo mix di acque diverse crea un ambiente unico nel suo genere, perfetto per la coltivazione di cozze, che negli ultimi anni è diventata sempre più difficile a causa dei livelli di inquinamento delle acque e dell’aumento delle temperature. Se nel caso del mar Menor la maggior fonte di inquinamento sono i residui chimici dell'agricoltura praticata lungo le sue rive, nel caso di Taranto l’inquinamento è legato alla presenza di un’enorme acciaieria che riversa inquinanti nell’aria e nell’acqua. Sono anni che si sta provando a ridurre il livello di inquinamento della zona e seppur sono stati fatti molti passi avanti c’è ancora molto da fare. Recentemente un gruppo di scienziati sta provando ad abbassare i livelli di inquinamento dell'acqua usando delle piante, in particolare dei pioppi, che attraverso le loro radici riescono a catturare alcuni degli inquinanti presenti. L'obiettivo è rendere la coltivazione delle cozze, tradizione legata a doppio filo alla storia della città, più stabile e sostenibile. La burocrazia e la mancanza di fondi però limitano fortemente gli sforzi degli scienziati (Bbc).
Il progetto del genero di Trump in Albania. Il delta del fiume Vjosa, in Albania, è uno spettacolo naturalistico, quasi intatto, un paradiso per uccelli come fenicotteri, pellicani e aironi. Il delta è riconosciuto a livello europeo come un sito dall’alto valore ambientale e paesaggistico. Come già scritto in passato in questa newsletter, Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, ha da tempo messo gli occhi su questo pezzo di costa incontaminata per costruirvi un resort di lusso. L’Albania è un paese tra i più poveri in Europa e ha un disperato bisogno di sviluppo economico, ma non tutti sono d’accordo che cementificare tratti di costa ancora intatti sia la direzione da prendere. I rapporti tra i Kushner e il presidente albanese Edi Rama pare siano ottimi e abbiano aiutato nell’ottenere i permessi necessari nonostante i vincoli ambientali e i dubbi di molti residenti e organizzazioni non-governative. Nel mentre sono già iniziati i lavori per la realizzazione di un aeroporto nuovo di zecca sulle rive del delta che dovrebbe facilitare l’arrivo dei turisti e le successive fasi del progetto. Le foto che accompagnano questo articolo del New York Times rendono molto bene l’idea del paesaggio naturale che si rischia di perdere una volta e per sempre.
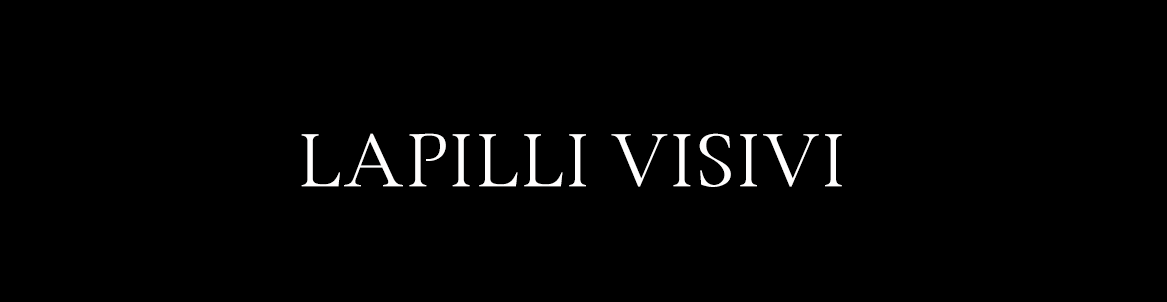
Laghi evanescenti. Ci lasciamo con un pezzo interattivo che ci porta in Turchia, dove si stima che 186 dei circa 240 laghi del paese si siano prosciugati negli ultimi 60 anni. In altre parole, più del 77 per cento dei laghi turchi è scomparso dal 1965 a oggi e i motivi sono svariati. Da un lato ci sono le temperature che aumentano a livello globale, maggiore evaporazione e generale inaridimento in certe regioni del pianeta. Dall’altro ci sono delle ragioni squisitamente locali: cattiva gestione delle risorse idriche, irrigazione eccessiva per colture che consumano molta acqua, inquinamento e pochi controlli. La buona notizia è che, come abbiamo spesso riportato in altri casi, con una migliore gestione delle risorse idriche e un’agricoltura meno intensiva, si potrebbe fare tantissimo per ripristinare parte dei laghi perduti (Scrolli).


GUGLIELMO MATTIOLI
Producer multimediale, ha contribuito a progetti innovativi usando realtà virtuale, fotogrammetria e live video per il New York Times. In una vita passata faceva l’architetto e molte delle storie che produce oggi riguardano l’ambiente costruito. Ha collaborato con testate come The New York Times, The Guardian e National Geographic. Vive e lavora a New York da più di 10 anni.Grazie per aver letto fino a qui. Ci vediamo a giugno, o prima con Lapilli+.
Se questa newsletter ti è stata inoltrata, per continuare a riceverla puoi iscriverti qui. Lapilli è distribuita gratuitamente, ma puoi sostenerci destinando il tuo 5x1000 a Magma Aps (C.F. 96511280586) o con una piccola donazione (anche con bonifico intestato ad Associazione Magma APS, Iban: IT34B0623002812000030639558), grazie!
Lapilli è la newsletter che raccoglie ogni mese notizie e approfondimenti su ambiente e Mediterraneo apparsi sui media e selezionati da Magma.

